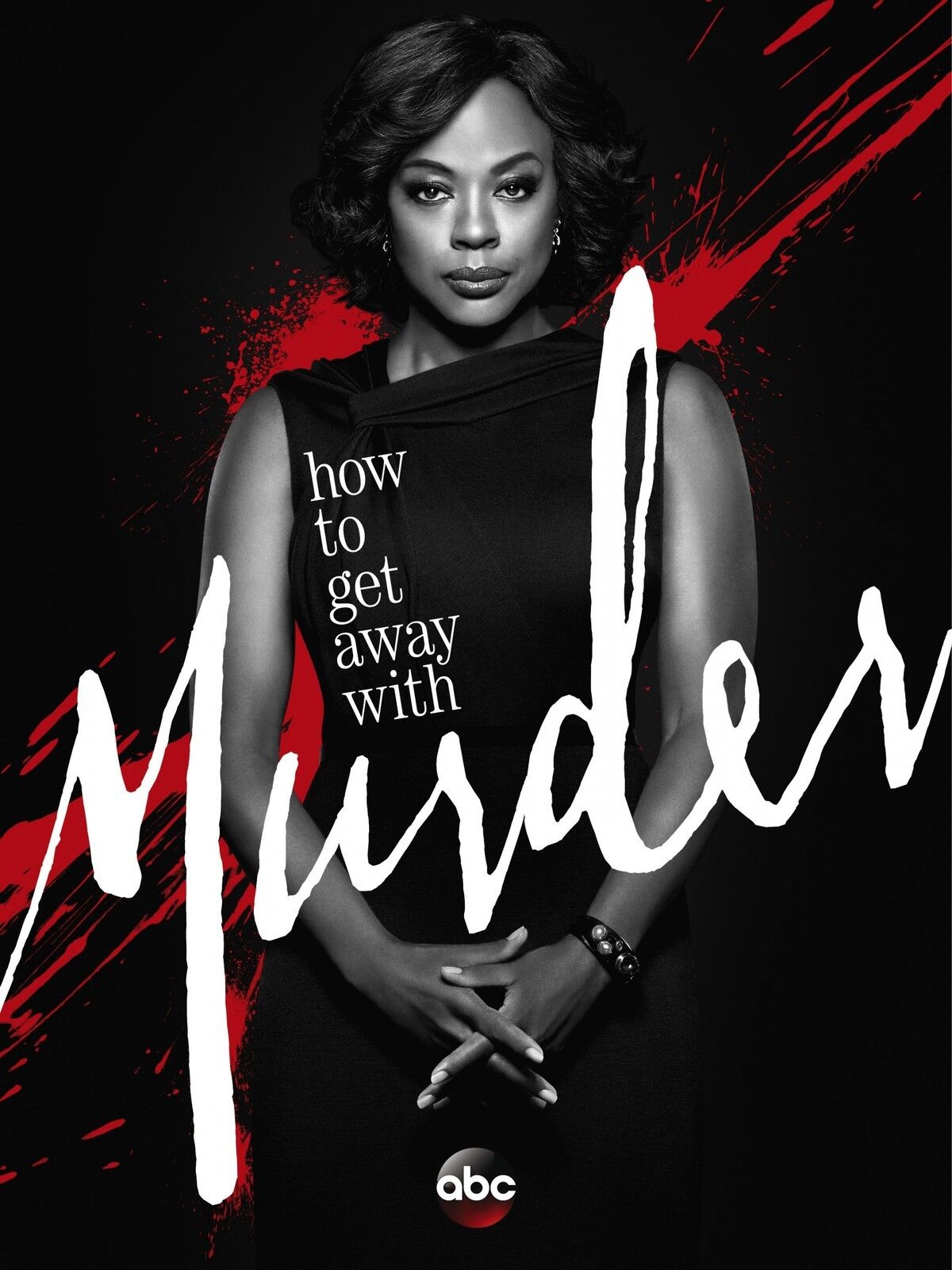Dal mondo nuovo a Netflix
Leggi l'articolo

- Visioni
- |
- Pubblicazione: 25 lug 2023
- |
- Scritto da Elena Cardillo
La meccanica delle immagini in movimento ha poco più di un secolo, se escludiamo gli antenati fatti di lanterne magiche (dal ‘600 in poi) e una miriade di meravigliosi apparecchi apparsi soprattutto lungo tutto l’800: dal mondo nuovo, ai vari: fenachistoscopio, stereoscopio, zootropio, prassinoscopio, kinetoscopio… tutti prodigi per regalare allo sguardo il movimento di immagini fisse. Se escludiamo la lanterna magica (nelle sue diverse evoluzioni settecentesche), tutte queste macchine “scopiche” erano concepite per una visione individuale: un marchingegno per uno spettatore.
Si sa, lo scatto in avanti del cinematografo è dare vita alla visione collettiva, a un’idea nuova e meravigliosa di socialità, dove il pubblico, riunito in un luogo silenzioso e buio, assiste all’unisono ad un evento, un racconto per immagini in movimento che ha un prologo, uno svolgimento e un epilogo. Spettatori che, nella condivisione, empaticamente partecipano al flusso delle immagini.
Non è una lezione di cinema, per carità, ce n’è tante in giro e di autorevoli. È una premessa a volo d’uccello per planare nel mondo di oggi.
Ed è strano perché, se il cinema ha macinato 128 anni di spettacolo collettivo (dal 28 dicembre 1895 al Salon indien du Grand Café del Boulevard de Capucines a Parigi, con il brevetto dei Fratelli Lumière), oggi, alle prese con una visione cinematografica sempre più in crisi e con la necessità di inventare forme, luoghi, situazioni, abbonda un’idea di visione filmica sempre più contratta, sempre più votata alla solitudine, all’esperienza individuale o comunque per pochi intimi. Un movimento che sembra portare indietro lo sguardo e gli animi, in una sorta di inversione della socialità.
La serialità televisiva e ancor più la serialità on demand, riporta il nostro sguardo dentro i confini di un apparecchio individuale (televisore, pc, smartphone); una mono visione che però (a differenza dei vari -scopi dei secoli passati) è dedicata alla collettività: il pubblico in massa c’è (una massa enorme) ma è fatto di persone sole. E poi, esattamente come in pieno Ottocento, solamente dopo la visione ogni spettatore può (se vuole) interagire con chi come lui ha sperimentato il mezzo e il contenuto.
Certo, facciamo tutti i debiti distinguo. Due secoli fa non c’era la serialità narrativa (non visivamente), e non c’era alcuna tecnologia in grado di connettere le persone, la rete era quella del telegrafo, poi del telefono, e non esisteva un flusso di contenuti e di scambi come lo concepiamo oggi.
Nonostante questo, tengo fermo il paragone. Perché la visione solitaria ha regole inviolabili: quelle di un tempo scelto, dedicato, assaporato (per minuti o per ore, non importa), vedendosela con se stessi.
A me Netflix, Prime Video, Sky, Disney+, Apple Tv, Chili, Mubi, ecc., ricordano il mondo nuovo, lo zootropio e tutte le altre macchine “scopiche” antenate del cinema. Forse sto bestemmiando.
Ma il punto è che, quando si ha un’attrazione fatale per le storie in movimento, si trova il bello e il senso in ogni visione.
Il cinema nella sala è e resta per me la visione delle visioni, l’impareggiabile esperienza dell’immaginario, del cuore, dei pensieri e dell’animo. Ci sono cresciuta grazie a mio padre, al suo contagio immaginifico; poi, un po’ per volontà un po’ per caso, è diventato umilmente il mio lavoro. Spero con tutta me che nel tempo il cinema trovi vie, luoghi, forme per non sparire dallo schermo grande, dal buio in sala, ad avvolgere molti sguardi riuniti e mai soli.
Ma ci sono le serie, nelle quali l’industria visiva ha concentrato alla massima potenza le energie e i capitali, stagione dopo stagione.
Le serie però nascono in pieno Novecento. Allora li chiamavamo telefilm, oppure sceneggiati. Non cambia molto, penso a “Star Trek” (nato negli anni ’60, USA, evoluto e declinato poi in film seriali e in nuove serie), oppure “Spazio 1999” (anni ’70, telefilm britannico) o “Mork e Mindy” (a scavalco tra gli anni ’70 e ’80, USA); o a tanti sceneggiati italiani: da “I promessi sposi”, 1967, con Nino Castelnuovo e Paola Pitagora, a “Le inchieste del commissario Maigret”, 1964-1972, con il mitico Gino Cervi, o ancora “La cittadella”, 1964, tratto dal romanzo di Cronin, con Alberto Lupo e Anna Maria Guarnieri.
Sembra ci sia un abisso tra queste immagini lontane e quelle di “Sons of Anarchy”, “Bordertown”, “Breaking Bad”, “La casa di carta”, “Dark”, “Jack Ryan”, “New Amsterdam”, “The Crown”, “Bridgerton” (e il delizioso prequel “La regina Carlotta”), “Borgen”, o di tante altre serie.
Invece trovo ci sia un filo sottile e costante a tenerle insieme, un filo temporale, dove a cambiare sono le ambientazioni, il ritmo, la tecnologia, i contesti sociali e culturali, ma identico è il meccanismo: una storia a puntate costruita sull’attesa di quel che accade dopo, dove i personaggi prendono carattere, cambiano, scompaiono, tornano, diventano per lo spettatore punti di riferimento. E le immagini sono pagine da sfogliare come nei romanzi d’appendice.